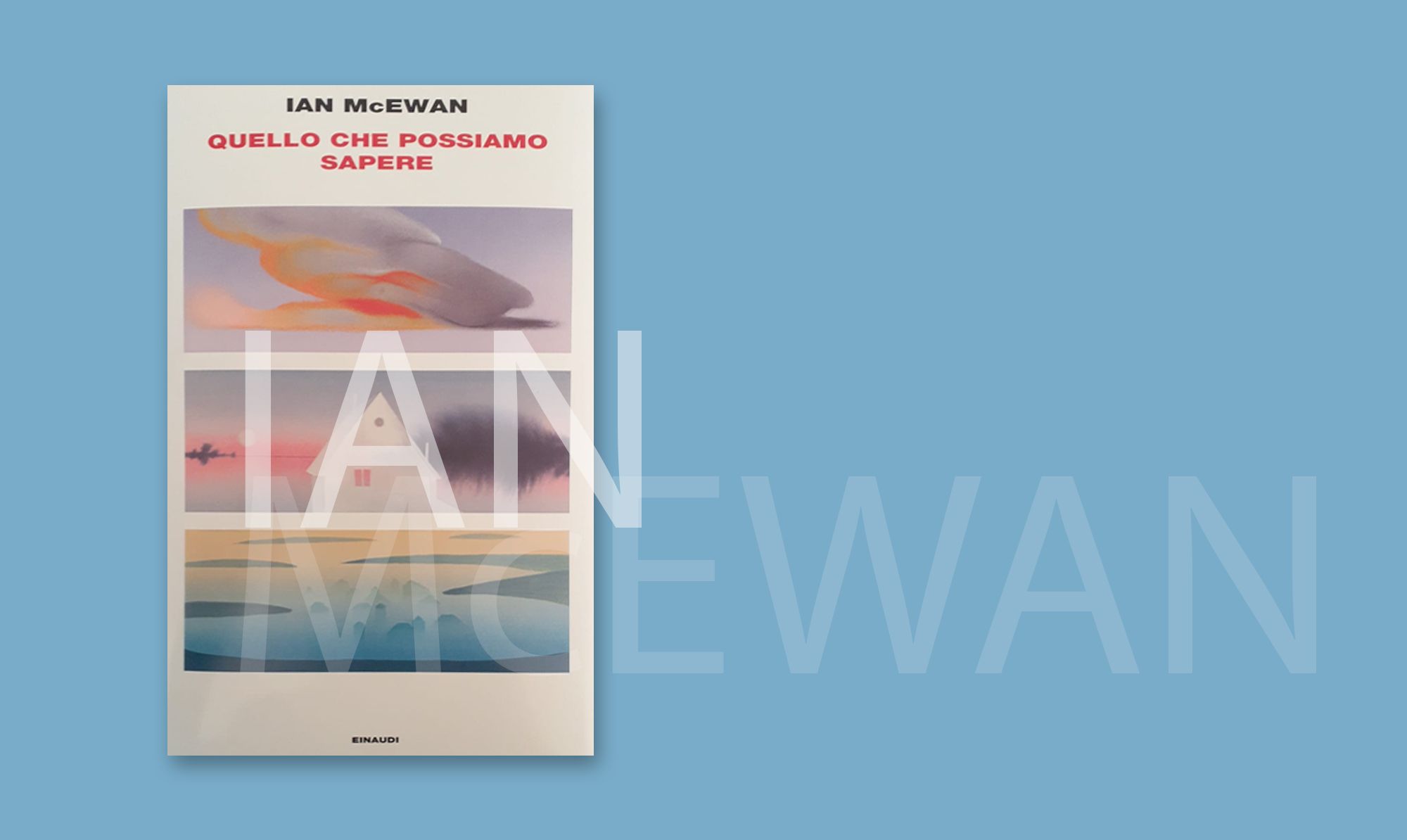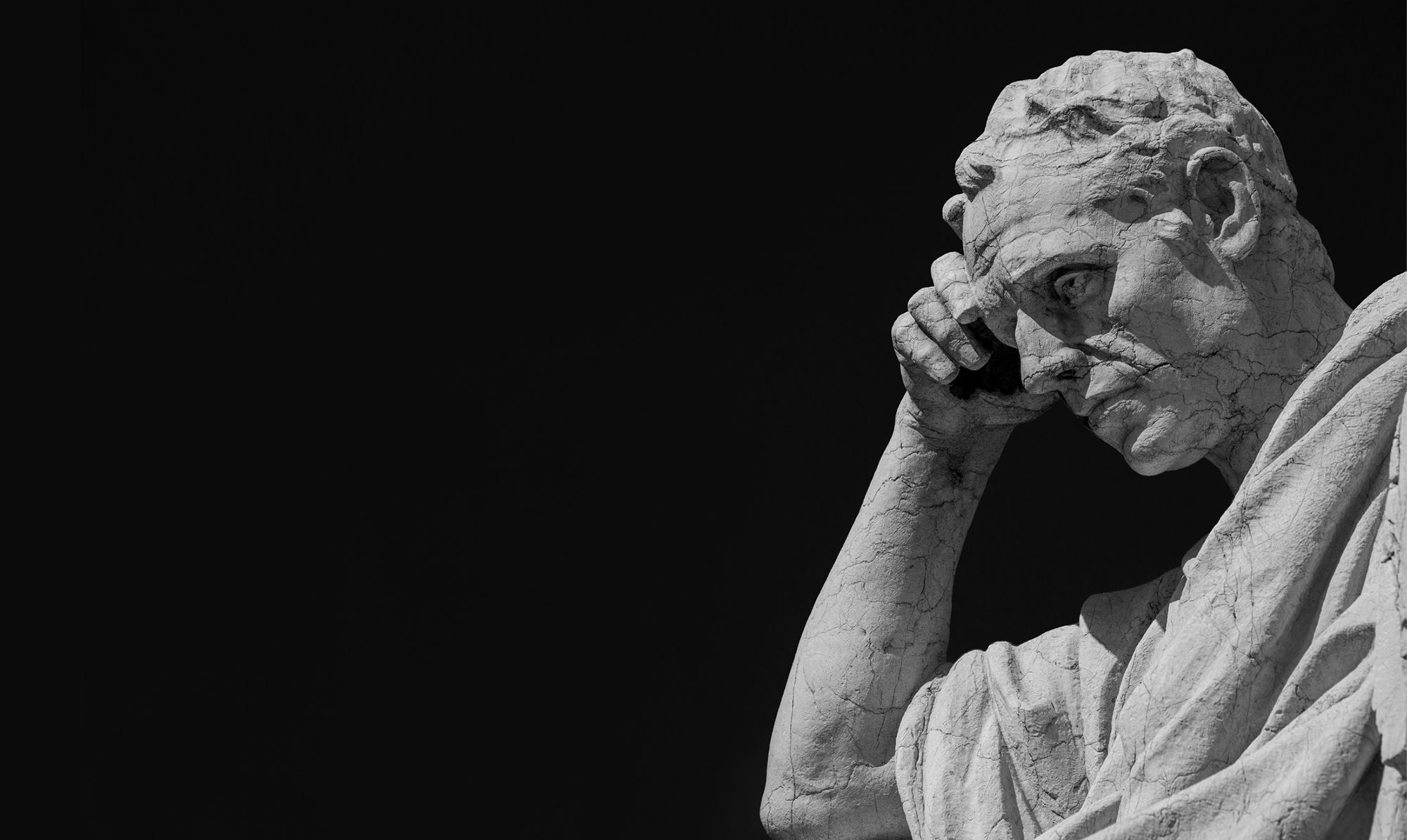Luce della mia vita.
Quello che mi piace in un’opera d’arte.
Non mi permetterei mai di dire che sono un’esperta d’arte. Fin dall’inizio di questa blog-avventura ho dichiarato di non essere un’esperta di alcunché, ma solo una persona curiosa, una che cerca di capire le cose, almeno quando a governare il mio sentire è la testa e non la pancia. E già questo è fatto raro. Ci sono quadri dell’arte contemporanea - spero di non fare pasticci lessicali nelle mie definizioni - che non mi dicono assolutamente nulla, anzi, se possibile mi mandano in bestia. In diverse occasioni ho sostenuto violente - già, proprio! - discussioni sulle famose tele tagliate a coltello di Fontana il cui significato mi sfugge - come mi sfugge e mi manda ai matti l’idea che i collezionisti spendano cifre da capogiro per averli - e continuerà a sfuggirmi finché avrò vita, nonostante le dotte disquisizioni di chi cercava di spiegarmi ragioni, origine ed evoluzione dell’artista in questione, il suo percorso insomma e il motivo per cui fosse arrivato a quel tipo di arte. Anni fa ci aveva provato la mia amica Giuliana, laureata in storia dell’arte, in un grazioso museo scozzese il cui ultimo piano era interamente occupato da quadri surrealisti, iperrealisti, va be’ va’: astratti. Avendo notato che li esaminava rapita le ho chiesto di fornirmi spiegazioni perché a me, francamente, comunicavano zero. L’ho ascoltata con attenzione, giuro, ma non ho cambiato opinione pur avendo compreso benissimo la lezione impartita con calma e pazienza. Sono una zuccona, lo ammetto, ma rivendico il mio diritto a dichiarare cosa mi piace e cosa non. Un’opera d’arte, qualunque opera d’arte, deve parlarmi, la devo sentire nella testa e nella pancia, deve provocarmi un’emozione se possibile positiva, farmi riflettere, suscitare, quando non è più di fronte a me, un ricordo e un pensiero. In caso contrario, ciao e fine della storia.
E dunque? Dunque dichiaro il mio amore assoluto per i quadri di Turner visti e rivisti nella vecchia Tate Gallery nei vari periodi trascorsi a Londra. Quelle antiche navi maestose e possenti che avevano sfidato gli oceani insieme al loro carico umano di marinai, nostromi e capitàni, le vele spiegate al vento, e che ora, come anziani in pensione e in disarmo, compiono il loro ultimo viaggio verso lo smantellamento, mi hanno sempre provocato dolore, rimpianto, tenerezza. Sono umane, piangono, non vogliono morire. Piegate su un fianco, le vele strappate, il mare che ne lambisce i fianchi sospingendole verso l’estremo riposo, sono la rappresentazione di un’epoca che si chiude con l’arrivo del vapore, dei transatlantici, della velocità. Che meraviglia e quanta tristezza. E poi c’è un quadro di John Everett Millais, La lettera di rilascio che non ricordo più se fosse nella vecchia Tate o alla National Gallery. Di sicuro non mancavo mai di passare qualche minuto di fronte a quest’immagine di incredibile bellezza, pazienza e devozione. Una donna regge il figlioletto con un braccio e con l’altra mano consegna alla guardia la lettera di scarcerazione o rilascio del marito. Lui lo si vede di spalle, un braccio al collo, ferito. Le appoggia il capo all’omero, sembra chiedere perdono e ringraziarla. In piedi, le zampe appoggiate ai due, un cane festante. Ma è il volto di lei a essere spettacolare. Dentro c’è una storia intera, una fierezza e un coraggio senza fine. È il volto di chi ha sopportato e sopporterà di tutto, perché la vita è lunga e quello è il suo compagno, in salute e malattia, in ricchezza e povertà. Dall’abbigliamento si direbbero scozzesi. Cosa ci raccontano? Un soldato che aspettava la moglie con la lettera di congedo? O un uomo che si è ubriacato, è stato ferito in una rissa e si è fatto una notte al gabbio? Qualunque sia la loro storia è il volto di lei, l’unico di fronte e illuminato, a raccontarla. Non so cosa pensasse Millais quando l’ha dipinto, ma quello che io sento nel cuore ogni volta che lo guardo è una musica, un inno alle donne.
Ma il quadro che sopra ogni altro amo alla follia è L’impero delle luci di Magritte. È conservato a Venezia, a Ca’ Venier dei Leoni, nel Museo Guggenheim, quello che un tempo era la casa di Peggy, ex moglie dell’artista Max Ernst, nipote del magnate americano Solomon Guggenheim, e che ora riposa in un’urna posta in un angolo del giardino accanto alla lapide con i nomi dei suoi cani. Un luogo già di per sé fuori dal mondo, come molti altri luoghi di Venezia, la mia città del cuore - ci potrei vivere senza problemi. Fuori dal mondo non fosse per le moltitudini che affollano il museo Guggenheim in ogni stagione dell’anno. L’ho visto la prima volta nel 1989, di passaggio a Venezia con mia madre. È stata lei a insistere e ancora la ringrazio. Anche lei amava L’impero delle luci e in quella occasione ne comprammo una bella riproduzione in foggia di manifesto che ancora conservo. C’è una casa. La luce di un lampione illumina la porta d’ingresso. Un’altra luce, fioca, s’intravede da una finestra, all’interno. Di fianco alla porta, un grande albero svetta verso il cielo, un cielo pomeridiano più che notturno. Potrebbe essere uno di quei tramonti estivi, quando l’ombra copre già una parte della terra, ma altrove è ancora chiaro. Si è detto che Magritte intendeva con questo quadro mettere in dubbio la nostra percezione del mondo - credi sia giorno? Invece è notte. E viceversa. - Per me, significa tutt’altro: sono le luci e le ombre delle nostre vite, ciò che siamo e ciò che nascondiamo. Sono le case intraviste da un treno che corre verso una destinazione ignota, quei rettangoli di luce dietro i quali si svolgono esistenze che non sono la nostra, ma potrebbero esserlo, esistenze che ci è solo concesso immaginare. È la mia casa, quando arrivavo la sera dopo una lunga giornata di lavoro e mi accoglievano le luci dietro i vetri e vedevo mia madre muoversi da una stanza all’altra. Sono a casa, pensavo, finalmente a casa. Home, non house, direbbero gli inglesi che di parole ne hanno ben due, e home è perfetta: calda, luminosa, avvolgente. Grazie Magritte e grazie mamma.
C’è un’opera d’arte che amate così tanto da essere disposti a rubarla?